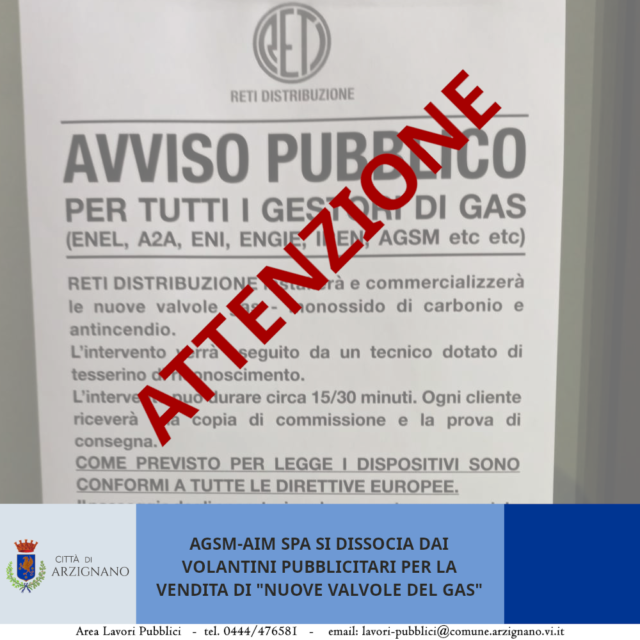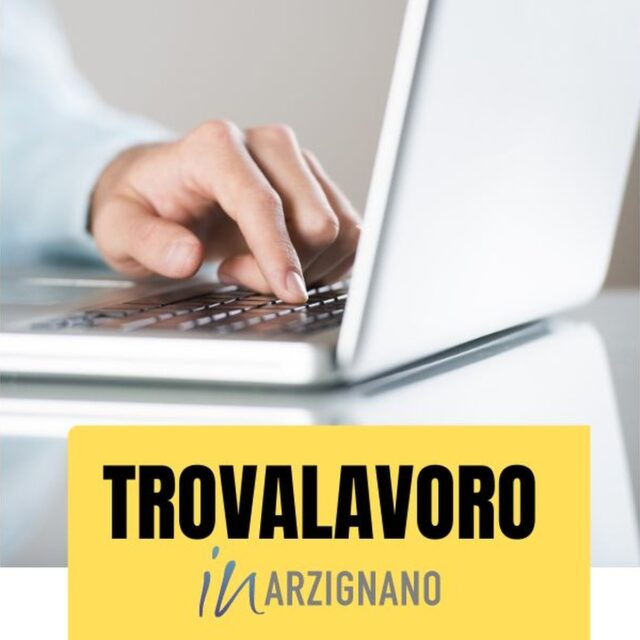Il sindaco Alessia Bevilacqua: “L’Amministrazione comunale ha iniziato da qualche anno un percorso per ricordare e onorare i propri concittadini che hanno vissuto gli orrori della prigionia, accettando una vita di stenti, umiliazioni e sofferenze pur di non tradire il giuramento all’Italia, pur di non dover combattere contro altri Italiani, pur di mettere fine a una guerra che li aveva stremati.
Le ricerche dall’archivio comunale e dagli archivi dell’Associazione Nazionale ex Internati (A.N.E.I.), sede di Vicenza, hanno permesso di ritrovare circa 300 nominativi di militari arzignanes internati nei campi di concentramento dopo l’8 settembre 1943, che con il loro rifiuto di aderire alla Repubblica di Salò, hanno messo in atto una diversa Resistenza, silenziosa e non violenta.
Arzignano ricorda anche i numerosi deportati civili e politici, costretti al lavoro
coatto nelle fabbriche belliche del terzo reich; la medaglia d’argento al merito civile, conferita dalla Presidenza della Repubblica alla nostra Città nel 2022, ricorda altresì il coraggio degli operai delle Officine Pellizzari, che reagirono con lo sciopero alla richiesta dei tedeschi di spostare in Germania parte delle maestranze, pagando la scelta con la vita o con la prigionia.
Al sacrificio di tanti nonni e padri l’Amministrazione comunale vuole dedicare la prestigiosa opera dell’artista arzignanese Domenico Scolaro, che con maestria e passione ha saputo ben rappresentare la sofferenza dei tanti deportati, così come la disperazione di un’attesa, spesso vana, di troppe madri, mogli e figli.
In un contesto come quello attuale, dove ogni giorno riviviamo l’orrore della guerra, anche in luoghi non troppo lontani da noi, riteniamo che ricordare la dignità, la coerenza e la forza di questi nostri concittadini possa e debba essere monito per difendere i principi sui cui l’Italia repubblicana è stata costituita, vero patrimonio da tutelare con l’impegno di tutti.
Ringrazio Domenico Scolaro, per la sua opera e per la sua sensibilità, l’Associazione Miti e Mete per la collaborazione e tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione di un manufatto che abbellisce il centro cittadino, che ci onora e ci commuove”.
IL MONUMENTO AI DEPORTATI
Un monumento racconta una storia affinché non si dimentichi.
Quella dei deportati arzignanesi che commemoriamo è innanzitutto una storia umana di abbandoni: della propria casa, della propria terra e delle persone care, che sta dentro a una storia mondiale più grande: di guerra fra le terre e di orrori fra le persone.
A Domenico Scolaro spetta l’onere di un progetto artistico che sia in grado di fare memoria, una creazione che non solo faccia sapere le vicende storiche dei concittadini deportati, ma ne comunichi più profondamente le vicende umane. E affinché divengano nostre, affinché il ricordo ci rimanga quanto più attaccato possibile, il sentimento che fa nascere l’opera non può che essere vivo e sincero.
Coinvolto dall’Amministrazione, l’artista vive lo stato d’animo di Arzignano che ricorda i suoi internati e lo muta in arte secondo una rigorosa e personale ricerca estetica. Non si sottrae alla responsabilità del creare per lo spazio comune, sfida difficile che ha già accettato negli ultimi 25 anni, dando vita a grandi sculture fra le quali La porta del Giubileo nel piazzale della chiesa di San Bortolo e Il cammino al Parco dello sport.
Scolaro ama la materia, dimensione fra le più resistenti per un artista, che deve fare i conti con durezza e durevolezza di materiali “eterni” e infondervi l’espressivo. Sceglie per le grandi strutture il vetro e l’acciaio, compone in cartapesta su rete metallica le due famiglie di sculture, mentre le testine vengono fuse in bronzo e lucidate.
L’installazione al suo esterno è una tassellatura di geometrie reali, le due piramidi gemelle dominano eleganti l’equilibrio dell’opera e i loro vertici paralleli sono punti di fuga verso l’infinito. L’artista taglia lo spazio a triangoli con il metallo e a facce spioventi rivela col vetro un dentro: due grembi geometrici.
Fortissimi i significati simbolici delle forme, intellettuali e spirituali, le geometrie rievocano l’atmosfera quasi irreale della filosofia metafisica, così come la suggestione delle piramidi rievoca un senso di storia che conserva il passaggio dell’umano.
Collocate fra le trasparenze, le figure eteree riempiono di vita il vuoto. Un vuoto non vuoto. Scolaro non ha mai nascosto di attingere idee dai grandi maestri del passato, la sua predilezione per la transavanguardia e il richiamo a Giacometti in questo caso paiono evidenti.
Le figure eteree si ergono verso l’alto, si elevano informi e informali e così scarnificate e prive di arti, sembrano bloccate, quasi smarrite. È un fermo immagine quello che i soggetti dell’artista raccontano: una partenza forzata, ma altresì un rimanere in attesa, un sostare fatale senza fare, né poter fare. I due grembi separano uomini da donne e bambini, così come sarà accaduto alla partenza in quella stessa stazione dove sono collocate adesso. Così come accadde poi nei campi di concentramento di allora.
Separati ma ancora in contatto, questo l’effetto reso dal vetro, simbolico di un vedere non più fisico ma spirituale; una vicinanza documentata da lettere e cartoline dei militari per le famiglie lontane.
Un vuoto non vuoto che crea una sospensione, un equilibrio fra presenza e assenza, un dialogo fra l’adesso e l’allora.
Quella dell’artista è una continua ricerca, non di perfezione, ma di elevazione del ricordo, un tentativo che visibilmente si traduce in una verticalità del monumento, nell’allungare verso l’alto le figure e le strutture, così come visto per altre opere fra cui i suoi noti cavalli in bronzo. Un ricordo che accudisce e restituisce affinché ci si possa riconoscere nell’unico elemento plastico dell’opera: i volti dei deportati.
Dopo aver colto luci e ombre dei protagonisti ed esserne rimasto lui stesso colpito, Scolaro ne rievoca l’aspetto e lo muta nella tensione espressiva delle facce bronzee, liberando una scena molto vicina al nostro immaginario umano.
Dare un volto significa per lui ridare dignità, raccontare quella storia umana di abbandoni di cui si è fatto carico con questo monumento, la vicenda dei deportati uomini e di donne, madri, sorelle, figli e amici… che li hanno a lungo attesi. Una storia nella storia.
Una condizione così al limite del comprensibile da risultare addirittura surreale, così come lo è l’installazione stessa, ma in cui proprio grazie ai volti possiamo immedesimarci.
Le sculture ci guardano e pretendono a loro volta di essere osservate; fra la gente, all’aria aperta, interrompono l’andamento della scena quotidiana, dando vita a uno strano intreccio tra il qui e l’altrove, tra il presente e il passato. Siamo invitati ad abitare l’opera da vicino, entrando con gli occhi, sedendo alla base, in una posizione da spettatori attivi.
Quella contemporanea è una società attraversata dalla pluralità, dal nomadismo, da valori talvolta in conflitto, ma che nello spazio pubblico in cui colloca un monumento cerca un luogo franco: un luogo dove la comunità incontra la propria memoria.
Testo: Elisa Spanevello